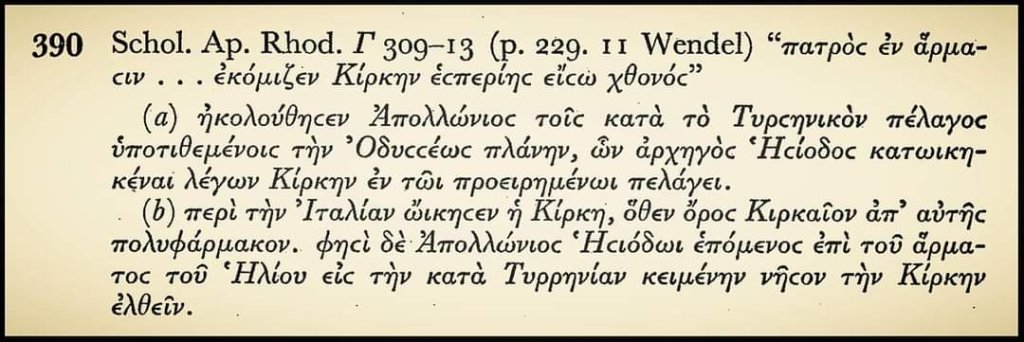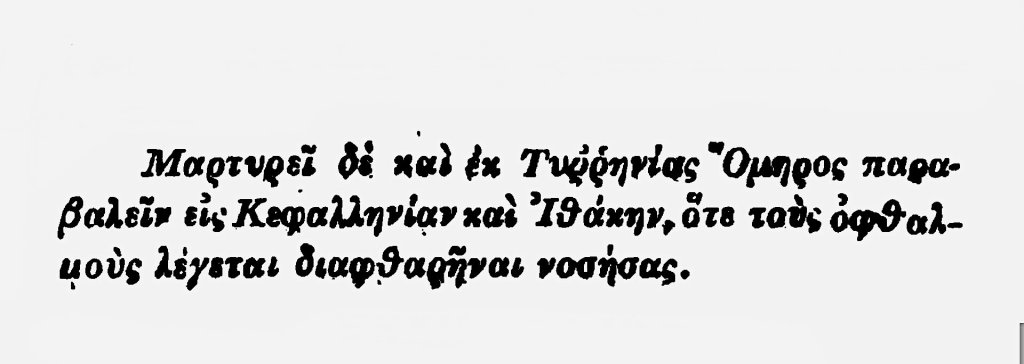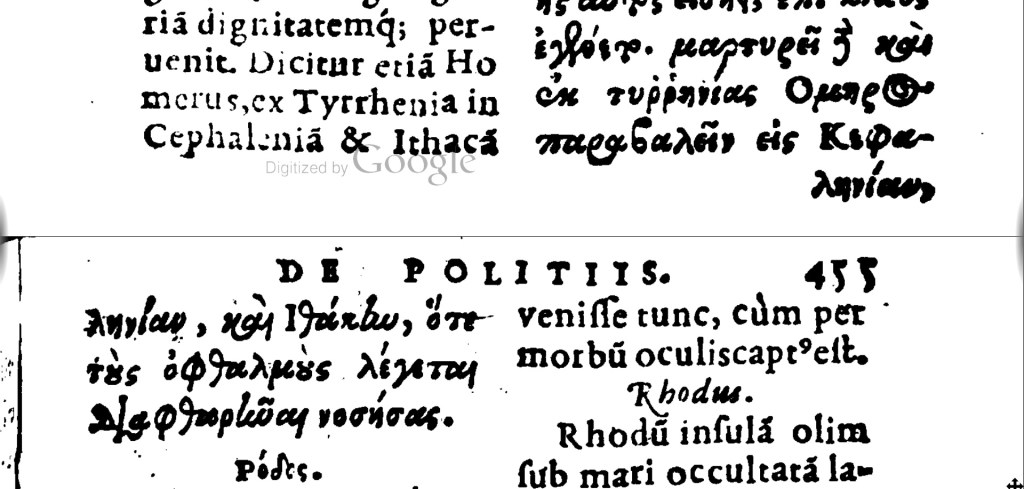Quando Sir Arthur Evans a Creta si trovó davanti le tavolette dell’Età del Bronzo, con splendide ed illeggibili iscrizioni in quei caratteri cosí originali, capí immediatamente di aver scoperto il sistema di scrittura di una grandiosa civiltà. Se il nostro avesse voluto attenersi alla storia che ci é stata tramandata, avrebbe dovuto affermare che si trattava della scrittura dei Pelasgi. Questo lo dico perché seppur sia vero che non sappiamo con certezza quali popoli abitassero Creta al tempo del Lineare A, sappiamo che un paio di secoli dopo l’isola ha una popolazione ‘multietnonima’. Secondo Omero infatti lí convivono Eteocretesi, Ioni, Achei, Dori e Pelasgi. Di questi ultimi sappiamo che erano “barbari” – che non vuol dire affatto “arretrati” ma piuttosto solo “che parlavano una lingua incomprensibile agli Ellenici”, – e che erano “famosi” – e questo aggettivo non è messo lí a caso. Anche se traduce un termine diverso da quello di “celeberrimi” usato da Esiodo per i Tirreni, sottende comuque una stessa forte “ammirazione” da parte degli autori greci nei confronti dei Pelasgi in genere e di quelli tra loro che erano Tirreni.
I Pelasgi erano considerati se non come autoctoni della Grecia, quantomeno i suoi più antichi abitanti tra quelli conosciuti dagli storici greci.
Probabilmente la loro diffusione nelle diverse zone del Mediterraneo era legata soprattutto a quella loro componente “talassocratica”, i signori della navigazione, che i greci identificavano con i Tirreni, etnonimo che include gli Etruschi propriamente detti, ma che ha un senso spesso molto più lato, tanto da far pensare che Tirreni potesse essere in alcuni casi sinonimo di Italici, in altri casi di Navigatori Pelasgi, in altri ancora forse anche di ‘Sardi’ e ‘Siculi’, esperti commercianti di ossidiana e marinai già dal V millennio avanti Cristo. Il fatto che i greci a volte confondessero tra loro questi antichi popoli di “celeberrimi e famosi barbari” potrebbe far pensare che sia dovuto a un accomunamento semplificativo di quelle genti che già abitavano quelle terre (Italia, Grecia, Creta, Anatolia, ecc.) dove loro giunsero ad ondate nel corso dei secoli, forse tra XXIII e XIII secolo circa.
Evans certamente sapeva che solo un popolo “famoso” poteva essere stato l’inventore di quello splendido sistema di scrittura. Peró quella scrittura si trova quasi esclusivamente a Creta, mentre dei Pelasgi sappiamo che erano stanziati in molte altre regioni della Grecia e non solo. Poco importa qui, per quanto ci proponiamo di scoprire qui, se in origine i Pelasgi siano arrivati nell’Egeo dall’Egitto, o istruiti nell’Epiro da immigrati sacerdoti egizi che li iniziarono ai loro misteri. Oppure se i Pelasgi si fossero ‘originati’ a Creta, in Tessaglia, in Arcadia, o addirittura in Italia. Se ci lasciassimo condurre nella ricerca da un paradigma che sostiene che l’origine di un’etnia complessa abbia una datazione e delle coordinate precise, noi abbandoneremmo l’epistemologia in favore della mitopoiesi. Dobbiamo cercare di mantenerci analiticamente lucidi e tenere a mente consapevolmente, quante e quali categorie strumentali e linguistiche usiamo per avanzare nella conoscenza, e in che misura queste compromettano la verità dei fatti storici come avvennero in sé e per sé.
ὁ μεγάλως ἀγρεύων ὡς·
πότνια Γῆ, Ζαγρεῦ τε θεῶν πανυπέρτατε πάντων
ὁ τὴν Ἀλκμαιωνίδα γράψας ἔφη
Il più grande cacciatore, potente come Gea, o Zagreo, elevatissimo sopra gli Dèi, come disse per iscritto uno degli Alcmenidi.
(The Etymologicum Gudianum s.v. Zagreus
(2.578 de Stefani) = Cod. Barocc. 50 ap. Cramer, Anecd. Oxon. 2.443)
Questo si dice di Zagreo prima della propagazione dei Misteri e dell’Orfismo in Italia ad opera di Pitagora. In seguito diventerà un dio morto, del quale il cuore soltanto viene salvato, per dar vita a Dioniso. Il nome Zagreo non sarebbe altro che Za- forte -agreo cacciatore. Non da sottovalutare la similitudine tra “za” e il primo nome di Zeus riportato da Ferecide: Zas. Interessante, seppur non pertinente, notare l’assonanza di uno dei figli di Circe col termine per “predatore/cacciatore” dalla radice αγρ-, nella Teogonia esiodea, Αγριον, fratello di Latino.
Erodoto conferma l’influenza dei Pelasgi sull’Attica, facendo riferimento a alcuni rituali religiosi importati sia dagli Egizi che dai Pelasgi e poi trasmessi da questi ultimi alle generazioni successive degli Elleni. Questo può essere corroborato dalla teoria di Strabone secondo cui i Pelasgi potrebbero avere radici egiziane. Erodoto specifica anche che gli Ateniesi erano già Elleni quando alcuni coloni Pelasgi raggiunsero l’Attica, e sembra che questi nuovi colonizzatori si siano semplicemente uniti alla popolazione elleno-pelasgica già presente.
Erodoto riporta anche l’episodio in cui i Pelasgi furono scacciati dall’Attica dagli Ateniesi. Inserisce questo evento quando spiega la conquista di Lemno da parte di Milziade – un’invasione che gli Ateniesi giustificano come una vendetta contro i Pelasgi. In realtà, questo episodio è tratto dalla Periegesi Ges di Ecateo di Mileto ed è interessante notare che questo passaggio rappresenta anche un primo esempio di disputa storiografica tra i due antichi storici e geografi su ciò che è eticamente “giusto” o “ingiusto”:
“Milziade, figlio di Cimone Coalemo, aveva così preso possesso di Lemno: dopo che i Pelasgi erano stati cacciati dall’Attica dagli Ateniesi, sia in modo giusto o ingiusto – perché su questo non posso dire altro se non ciò che viene riportato, e cioè: Ecateo, figlio di Egesandro, disse nella sua storia che era stato fatto ingiustamente; perché disse che quando gli Ateniesi videro la terra che si estendeva sotto l’Imetto, che avevano loro stessi dato per abitare come pagamento per il muro costruito intorno all’Acropoli in tempi passati, quando gli Ateniesi, dico, videro che questa terra era migliorata grazie alla coltivazione, che prima era cattiva e senza valore, furono colti da gelosia e desiderio di possedere la terra e così li cacciarono, senza addurre alcun altro pretesto; ma secondo il racconto degli Ateniesi stessi li cacciarono giustamente; perché i Pelasgi, stabilitisi sotto l’Imetto, fecero di ciò un punto di partenza e commisero ingiustizie contro di loro come segue: le figlie e i figli degli Ateniesi andavano sempre a prendere l’acqua alla sorgente di Enneacruno; perché in quel momento né loro né gli altri Greci avevano ancora servi domestici; e quando queste ragazze arrivavano, i Pelasgi, con malizia e disprezzo per gli Ateniesi, le aggredivano; e ciò non bastava loro, ma alla fine furono sorpresi nell’atto di tramare un attacco alla città: e i narratori dicono che dimostrarono di essere uomini migliori dei Pelasgi, poiché quando avrebbero potuto uccidere i Pelasgi, che erano stati sorpresi a tramare contro di loro, non scelsero di farlo, ma solo ordinarono loro di partire dalla terra; e così, partiti dalla terra, i Pelasgi presero possesso di diverse località più antiche e specialmente di Lemno. La prima storia è quella riportata da Ecateo, mentre la seconda è quella raccontata dagli Ateniesi”.
WSJR. Osiride è una delle principali divinità del pantheon egizio, noto principalmente per il suo ruolo di dio degli Inferi. Secondo la mitologia egizia, Osiride era il figlio maggiore nato da Geb, il dio della Terra, e Nut, la dea dei cieli. Tra i suoi fratelli minori c’erano Seth, il dio del caos e della guerra, e Iside, la dea della guarigione e della rinascita. Iside e Osiride alla fine si sposarono e divennero la prima regina e faraone d’Egitto. Insieme, hanno avuto un figlio di nome Horus, un altro dio ben noto nel pantheon.
Questa statua di Osiride è stata realizzata nel periodo tardo dell’antico Egitto.
La prima rappresentazione di Osiride trovata dagli storici risale al 2300 a.E.V. Inizialmente era adorato da piccoli gruppi di persone. Tuttavia, divenne famoso per la sua comune definizione di sovrano dell’aldilà, e i suoi adoratori gli attribuirono l’inondazione annuale del Nilo. Osiride era anche considerato il dio di:
Fertilità.
Agricoltura.
Risurrezione.
Vegetazione.
Giudizio dell’aldilà
Nella connessione tra Dioniso/Baccho e il sole, e tra Osiride padre di Horus, e le raffigurazioni di tutti questi come bambini divini e poi come vecchi barbuti, interessa molto il passo di Macrobio a proposito di Liber:
Macrobio: <<Quindi non vi è alcun dubbio che il sole e il padre Libero sono la stessa divinità … nelle statue il padre Libero è raffigurato ora come fanciullo, ora come giovane; inoltre con la barba e anche da vecchio … Queste differenze di età si riferiscono al sole, perché al solstizio d’inverno sembra appena un fanciullo, e con tale aspetto gli Egiziani lo fanno uscire in un giorno determinato dal sacro recesso del santuario; allora infatti, nel giorno più breve, sembra piccolo e appena nato. In seguito, allungandosi i giorni, nell’equinozio di primavera acquista forze come un adolescente ed è raffigurato con l’a spetto di un giovane. Quindi, al solstizio d’estate, quando raggiunge il massimo incremento, la sua piena maturità è rappresentata dalla barba. Poi, nel periodo in cui i giorni si accorciano, il dio viene rappresentato sotto un quarto aspetto, simile a vecchio.»
Il solstizio d’inverno può capitare tra il 20 e il 23 dicembre. Il rito egiziano che fa uscire, secondo Macrobio, il divino bambino fuori dal santuario, cade in perfetto sincrono col natale cristiano. Una divinità solare bambina nasce con il solstizio d’inverno, il dato astronomico attraversa le religioni e si afferma come rito transculturale.
VSIL etrusco, a nostro parere è la traslitterazione dall’egizio in etrusco fi WSJR, tipica la rotacizzazione inversa da R a L, passando dall’età del bronzo a quella del ferro, e dai sillabogrammi e geroglifici alle lettere alfabetiche. La connessione col sole e l’aura solare o sfera sulle loro teste nelle raffigurazioni delle due divinità le rendono ancora più vicine. Ovviamente funzioni e virtù non sono esattamente le stesse, ma poco sappiamo davvero a livello di narrativa mitologica etrusca per avere un’idea più precisa su chi fosse davvero VSIL, di solito fatyo cortispondere sbrigativamente a Helios greco.