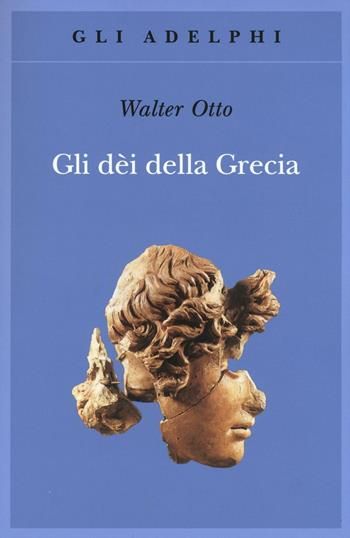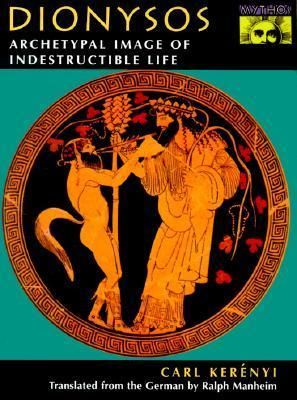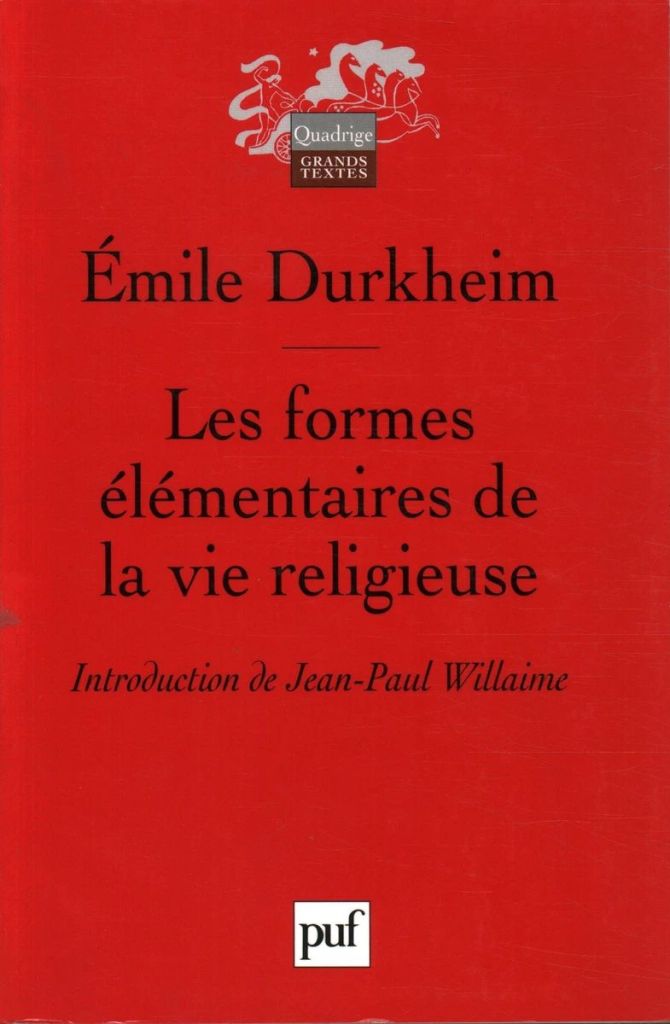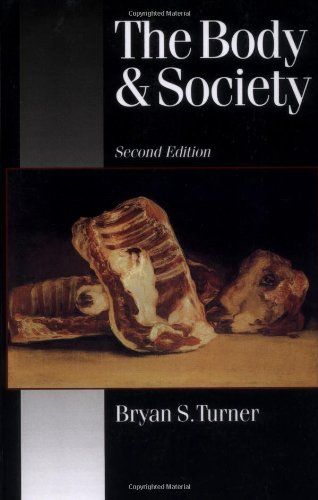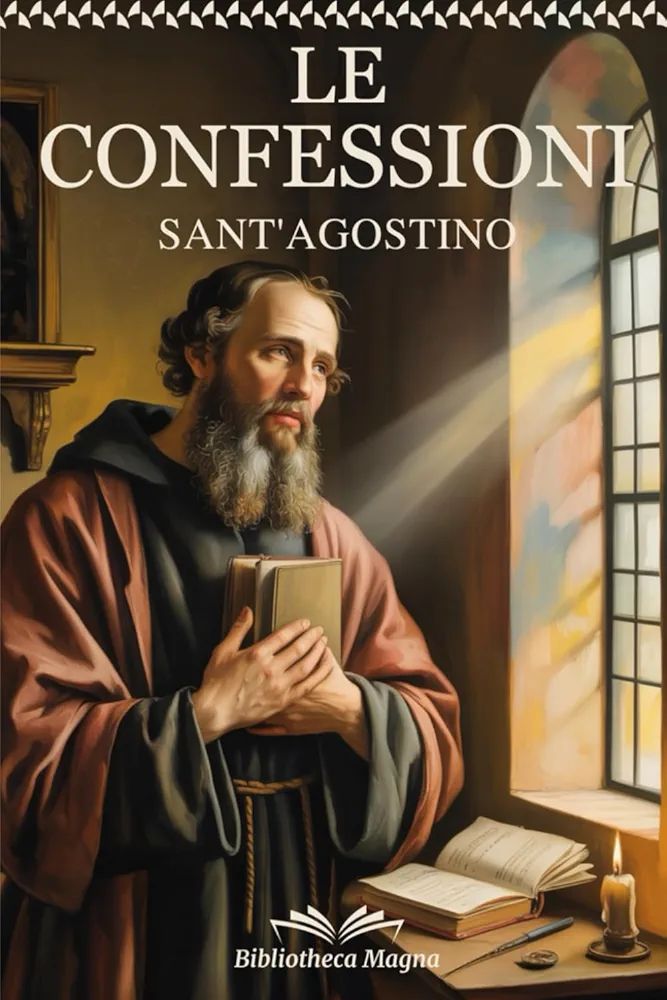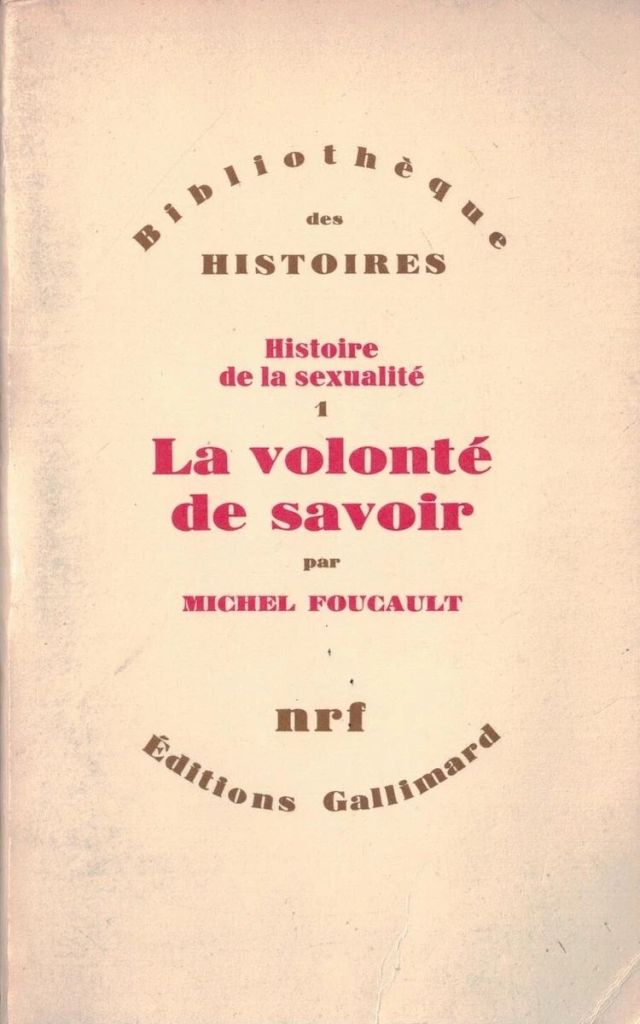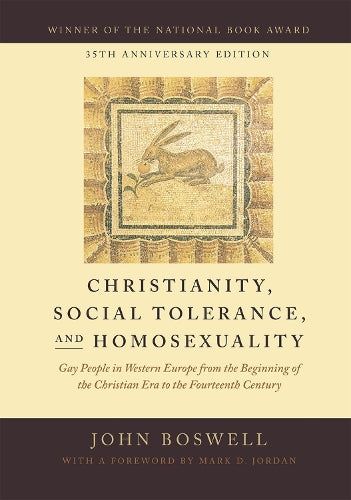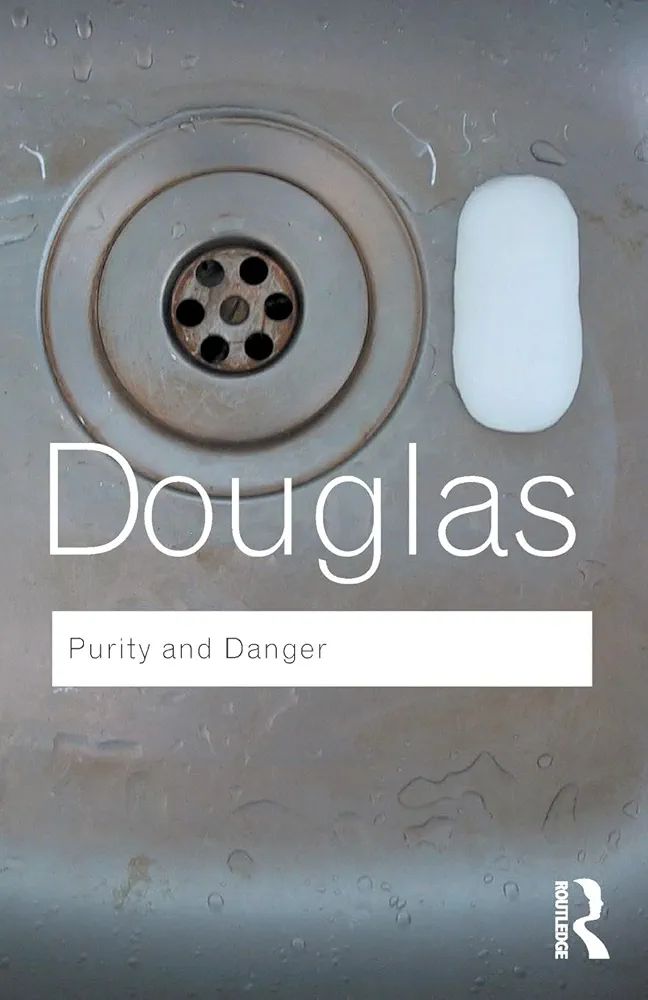Il modo in cui una società definisce ciò che è molesto, osceno o offensivo non è mai neutrale né naturale, ma dipende da un preciso regime simbolico, storico e religioso che determina quali comportamenti siano leggibili come accettabili e quali come perturbanti. In questa prospettiva, categorie come “ubriachezza molesta” o “oltraggio al pudore” non descrivono fatti oggettivi, bensì reazioni socialmente codificate a comportamenti che infrangono una determinata grammatica del corpo e della visibilità. La questione, dunque, non riguarda tanto l’atto in sé, quanto lo sguardo che lo interpreta e lo qualifica. Tale sguardo non è universale, ma storicamente situato, e trova una svolta decisiva tra il IV e il VI secolo d.C., nel passaggio dal mondo tardo-antico politeista all’egemonia dei monoteismi, in particolare del cristianesimo istituzionalizzato.
Nel mondo greco ed etrusco, come più in generale nel Mediterraneo antico, il corpo non è separato dal sacro. La sessualità, lungi dall’essere confinata alla sfera privata o interpretata come colpa, è in molti casi parte integrante del rito, della cerimonia e della relazione con il divino. Le feste dionisiache, i baccanali, i riti di fertilità, le ierogamie e le pratiche simboliche legate alla fecondità mostrano una concezione del desiderio come forza cosmica, non come deviazione morale. Dioniso, dio del vino, dell’ebbrezza e della perdita dei confini dell’io, incarna precisamente questa dimensione: l’accesso al sacro avviene attraverso la sospensione dell’ordine quotidiano, la trance, l’estasi e la dissoluzione temporanea dell’identità individuale, come messo in luce da Walter F. Otto (Die Götter Griechenlands, 1929, ma fondato su fonti classiche) e da Károly Kerényi (Dionysos, 1976, ma basato su un lavoro filologico precedente). Già Nietzsche, nella sua prima opera, aveva colto con estrema chiarezza la natura di questa opposizione, descrivendo il dionisiaco come principio di ebbrezza, unità e dissoluzione dell’individuo contrapposto all’apollineo, principio di forma e misura (Die Geburt der Tragödie, Leipzig, 1872).
In questo contesto, anche il vino e l’alcol non sono percepiti come semplici sostanze, ma come pharmakon, insieme cura e pericolo, mezzo di accesso a uno stato altro della coscienza. L’ebbrezza rituale non è disordine sociale, ma strumento di coesione e di partecipazione collettiva al sacro. Come ha mostrato Émile Durkheim, il rito non è l’espressione di un’emozione individuale, ma il luogo in cui la società si produce e si rafforza simbolicamente attraverso quella che egli definisce “effervescenza collettiva” (Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, 1912). In tale quadro, il comportamento che oggi verrebbe definito molesto o indecoroso è, in realtà, pienamente integrato in una struttura simbolica condivisa.
La frattura avviene con l’affermarsi del cristianesimo come religione dominante e, soprattutto, con la sua istituzionalizzazione tra IV e V secolo. Non si tratta semplicemente di un cambiamento di credo religioso, ma di una trasformazione profonda dell’antropologia occidentale. Come ha mostrato Peter Brown, il cristianesimo delle origini elabora progressivamente una nuova concezione del corpo, fondata sulla rinuncia, sull’ascesi e sulla problematizzazione del desiderio sessuale (The Body and Society, New York, 1988). Il punto di svolta decisivo è rappresentato dal pensiero di Agostino, per il quale la libido diventa il segno tangibile della caduta dell’uomo e della sua incapacità di governare pienamente se stesso. In opere come le Confessiones (circa 397–400) e il De civitate Dei (413–426), la sessualità viene interiorizzata come problema morale, e il desiderio viene separato dal sacro per essere collocato nell’ambito della colpa.
Con Agostino e con la teologia cristiana successiva, il corpo non è più il luogo dell’incontro con il divino, ma il campo di battaglia tra volontà e concupiscenza. Questo processo segna l’inizio di quella che Michel Foucault ha definito una vera e propria tecnologia del desiderio: la sessualità non viene semplicemente repressa, ma sottoposta a un regime di discorso, confessione e sorveglianza (Histoire de la sexualité, vol. I: La volonté de savoir, Paris, 1976). È in questo momento che pratiche fino ad allora tollerate o integrate in contesti rituali vengono ridefinite come peccato, e successivamente come reato. L’omosessualità, che nel mondo antico non costituiva un’identità ma una pratica situata e socialmente codificata, diventa progressivamente “contro natura”, come documentato storicamente da John Boswell (Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, Chicago, 1980).
Parallelamente, anche l’ebbrezza perde la sua valenza rituale e viene reinterpretata come perdita di controllo morale. Il vino, che nel cristianesimo sopravvive simbolicamente solo come sangue di Cristo in una forma rigidamente normata, viene separato dalle pratiche estatiche e dionisiache e ricondotto a una dimensione di uso moderato e disciplinato. L’ubriachezza diventa così non più una soglia verso il sacro, ma un segno di disordine, di deviazione e di pericolo sociale. In questo senso, ciò che viene punito non è tanto il comportamento in quanto tale, quanto la sua capacità di rendere visibile la fragilità dell’ordine simbolico fondato sul controllo del corpo e del desiderio.
Categorie come pudore, decenza e offesa nascono dunque come risposte reattive a ciò che eccede la norma. Come ha mostrato Mary Douglas, lo sporco e l’impuro non sono qualità intrinseche, ma definizioni attribuite a ciò che è “fuori posto” rispetto a un sistema di classificazione (Purity and Danger, London, 1966). Allo stesso modo, la nudità o l’ebbrezza diventano offensive solo all’interno di una cultura che ha investito il corpo di un valore morale negativo e che ha separato radicalmente il sacro dal sensibile. L’indignazione non difende l’individuo, ma l’ordine simbolico che garantisce la stabilità della comunità.
In questa prospettiva, l’idea stessa di “oltraggio al pudore” appare come una costruzione storica legata a un preciso momento della storia occidentale, e non come una categoria universale. La modernità eredita questa struttura, secolarizzandola ma non superandola: il peccato si trasforma in devianza, la colpa in disturbo dell’ordine pubblico, ma il meccanismo resta invariato. Come già Nietzsche aveva intuito, la morale non nasce dalla tutela della vita, ma dal risentimento nei confronti di ciò che sfugge al controllo e alla misura (Zur Genealogie der Moral, Leipzig, 1887).
Alla luce di tutto ciò, si può sostenere che tra IV e VI secolo d.C. l’Occidente compie un passaggio decisivo da una cultura del rito a una cultura della colpa, da una gestione pubblica e simbolica del corpo a una interiorizzazione morale del desiderio. Ciò che prima era esperienza del sacro diventa trasgressione, ciò che era differenza diventa peccato, ciò che era ebbrezza diventa disordine. Non si tratta di rimpiangere un passato idealizzato, ma di riconoscere che le categorie con cui oggi definiamo la molestia, l’offesa e il pudore sono il prodotto di una lunga storia di disciplinamento del corpo, e che senza questa consapevolezza ogni giudizio morale rischia di presentarsi come naturale ciò che è, in realtà, profondamente storico.